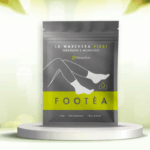La volpatura rappresenta uno dei problemi più insidiosi che possono colpire le coltivazioni di grano, specie in ambiente mediterraneo dove il cambiamento climatico e le piogge anomale degli ultimi anni hanno aumentato la frequenza e la gravità di numerose fitopatie. Si tratta di una alterazione cromatica delle cariossidi—ovvero la parte commestibile e ricca di amido della pianta—causata principalmente da funghi appartenenti ai generi Alternaria alternata e Bipolaris sorokiniana. La volpatura interessa esclusivamente i tessuti superficiali ma i danni che provoca a livello commerciale e agronomico possono essere gravissimi.
Cos’è la volpatura e come si manifesta
La volpatura del grano si riconosce per la colorazione bruno-nerastra che può comparire all’apice della cariosside o estendersi fino al solco ventrale, coinvolgendo l’intera superficie del chicco. Il fenomeno appare visibile soprattutto durante la fase di maturazione, quando i chicchi dovrebbero invece uniformarsi su tonalità dorate. Nonostante l’alterazione sia superficiale e non intacchi i tessuti più profondi, determina conseguenze notevoli, soprattutto per i produttori che puntano su una filiera di alta qualità e destinata alla pastificazione industriale o alla panificazione di pregio.
La presenza di chicchi volpati rende la semola o la farina risultante meno pure, con puntinature marroni che compromettono il tipico colore giallo richiesto sia dal mercato che dai regolamenti di settore. Questa perdita di uniformità cromatica è uno dei fattori causa dell’esclusione dal circuito commerciale più remunerativo e di numerose partite di raccolto che vengono declassate, con danni economici spesso insostenibili per i produttori.
Perché la volpatura è un problema per il raccolto
La gravità della volpatura è legata innanzitutto al fatto che le spighe infettate producono granella scura non idonea all’uso commerciale. L’impatto è duplice: da un lato, diminuisce il valore del raccolto per il produttore; dall’altro, compromette la stessa disponibilità di materie prime di qualità per l’industria alimentare nazionale.
Se non viene rapidamente individuata e gestita, la volpatura può portare a perdite di resa estremamente rilevanti. Alcune fonti riportano che, nelle stagioni in cui l’infezione non viene limitata, le perdite hanno raggiunto anche percentuali a doppia cifra rapportate alla produzione totale prevista, con ricadute sulla redditività ma anche sulla stabilità stessa del comparto cerealicolo. Il mercato penalizza ulteriormente la granella volpata rendendola non commerciabile per le industrie che richiedono alti standard igienici, estetici e funzionali.
È opportuno specificare che la presenza limitata di volpatura in piccoli appezzamenti destinati all’autoconsumo non comporta rischi rilevanti per la salute, né rende il prodotto inadatto alla panificazione domestica. Si tratta però di un problema sistemico per chi coltiva grano destinato all’industria alimentare.
Cause e modalità di diffusione della volpatura
Le cause della volpatura sono riconducibili, nella quasi totalità dei casi, a infezioni fungine. Gli agenti patogeni principali, Alternaria alternata e Bipolaris sorokiniana, trovano condizioni favorevoli allo sviluppo in presenza di elevata umidità, frequenti piogge, e temperature miti nel periodo compreso tra la fioritura e la maturazione del grano. Le spore fungine, presenti nell’ambiente, colonizzano le cariossidi in formazione, provocando la caratteristica colorazione scura che contraddistingue la volpatura.
Il rischio di diffusione è massimo negli areali caratterizzati da piogge tardive o dove le semine sono avvenute in terreni già contaminati. Anche l’uso di sorgenti di seme infette, pratiche agronomiche scorrette come la scarsa rotazione colturale e la mancata eliminazione dei residui di raccolto, favoriscono la persistenza e la propagazione del fenomeno. Eventuali danni da grandine, lacerazioni e lesioni causate da insetti o altre patologie possono ulteriormente predisporre le piante all’attacco di questi fitopatogeni.
Impatto agronomico e commerciale
La volpatura ha una rilevanza che va oltre l’aspetto estetico delle cariossidi. Essa compromette la qualità tecnologica del prodotto finale, penalizza la resa industriale e contribuisce alla perdita di competitività del comparto cerealicolo. Una granella volpata, risultando meno idonea alla trasformazione in semola e pasta di alta gamma, determina un abbassamento del prezzo finale pagato al produttore, e può addirittura renderla di seconda scelta, destinata all’alimentazione zootecnica o ad usi meno remunerativi.
Un fatto ancora più grave è che i funghi responsabili della volpatura, essendo fitopatogeni, possono dare origine anche alla produzione di micotossine, sostanze chimiche dannose per l’uomo e gli animali qualora la contaminazione superi le soglie di sicurezza. Questo aggiunge una valenza di sicurezza alimentare a un problema già gravissimo dal punto di vista economico.
Strategie di prevenzione e gestione della volpatura
Per contenere e prevenire la volpatura, la ricerca agronomica e le pratiche di campo hanno individuato diverse strategie, da impiegare sia nella selezione varietale che nella gestione agronomica:
- Utilizzo di varietà resistenti: la scelta di linee genetiche meno suscettibili alle infezioni di Alternaria o Bipolaris permette di limitare notevolmente la diffusione della malattia e le conseguenze economiche.
- Rotazione delle colture: alternare il grano con altre specie vegetali rompe il ciclo vitale dei patogeni e permette di ridurre il potenziale infettivo del terreno.
- Eliminazione dei residui infetti: la rimozione e il corretto smaltimento degli stocchi e delle spighe infette aiutano a contenere le fonti di inoculo di stagione in stagione.
- Monitoraggio e trattamenti fungicidi mirati: la sorveglianza delle colture, soprattutto nei periodi a rischio, e l’intervento tempestivo con principi attivi antifungini consentono di bloccare rapidamente la diffusione della malattia.
- Adozione di pratiche agronomiche corrette: una buona gestione dell’irrigazione, una densità di semina appropriata e una concimazione equilibrata riducono lo stress delle piante e la loro suscettibilità generale alle infezioni.
Nel territorio piacentino, per esempio, tra il 2019 e il 2020 il problema della volpatura ha visto l’intervento diretto dei consorzi agrari, che hanno fornito supporto e consulenza su varietà e tecniche da adottare per contrastare la malattia e contenere i danni. Reti di assistenza tecnica e formazione continua degli operatori agricoli risultano particolarmente efficaci nella gestione integrata di questa emergenza fitopatologica.
Volpatura, malattie fungine e sicurezza
La volpatura si inserisce in un quadro più ampio di patologie fungine che condizionano pesantemente il grano, incluse la fusariosi della spiga, le ruggini e la septoriosi. Tutte queste malattie, se non controllate, oltre a provocare perdite produttive compromettono la salubrità alimentare del prodotto: il grano infetto può contenere micotossine come il deossinivalenolo (DON), dannose per la salute pubblica e causa di blocco commerciale delle partite contaminate.
È importante applicare una gestione integrata della difesa che combina la prevenzione agronomica, la tempestività nei trattamenti fitosanitari, la scelta di varietà idonee e il continuo aggiornamento sulle innovazioni prodotte dalla ricerca. La sorveglianza e l’adozione di linee guida condivise dal settore permettono di ridurre al minimo il rischio di volpatura e garantire sia la qualità che la sicurezza del grano destinato all’industria alimentare e alla tavola del consumatore.
In definitiva, la volpatura non rappresenta solo un difetto visivo ma si configura come un grave ostacolo per l’economia cerealicola, la competitività delle filiere e la sicurezza alimentare collettiva, rendendo necessari costanti investimenti in ricerca, formazione e cooperazione tra produttori, tecnici e realtà istituzionali.