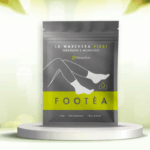La questione su quale sia il termine corretto per designare una donna che esercita la professione di architetto in Italia è da tempo al centro di dibattiti linguistici e sociali. Il tema si inserisce nel contesto più ampio dell’adeguamento del linguaggio di genere alle odierne necessità di inclusione e precisione formale. Negli ultimi anni, enti professionali, linguisti e la società civile hanno contribuito a stimolare una riflessione non solo sull’aspetto grammaticale della declinazione, ma anche sulle sue implicazioni culturali e identitarie.
Origine e evoluzione dei termini
Il termine architetto nasce come parola di genere maschile, proveniente dal latino architectus, e si è storicamente utilizzato in forma invariata sia per uomini che per donne nella professione. Tuttavia, la grammatica italiana consente la formazione del femminile per i nomi di professione, e la regola generale prevede la sostituzione della desinenza “-o” con “-a” per riferirsi a una donna (maestro/maestra, avvocato/avvocata).
Questo principio si applica anche al termine “architetto”, rendendo “architetta” una declinazione corretta dal punto di vista grammaticale. La conferma viene dalla posizione di linguisti come il professore Paolo d’Achille dell’Accademia della Crusca e dall’Ordine degli Architetti di Milano, che dal 2020 mette a disposizione un timbro ufficiale con il titolo architetta per le professioniste che lo desiderino.
Lingua, istituzioni e parità di genere
Il linguaggio istituzionale si trova spesso a confrontarsi con tradizioni consolidate e nuove sensibilità sociali. Secondo le “Linee guida per il corretto uso del genere nel linguaggio istituzionale” emanate da diversi enti pubblici e accademici, i nomi di professione sono di genere mobile, ovvero si declinano al maschile e al femminile seguendo le regole della morfologia italiana. L’uso del femminile per i titoli professionali non rappresenta solo una scelta stilistica, ma risponde a un’esigenza di precisione grammaticale e di visibilità delle donne nei ruoli tipicamente associati a figure maschili.
Nei documenti ufficiali e nella comunicazione pubblica, “architetta” è riconosciuto come termine lecito e corretto, analogamente a “avvocata”, “ingegnera” o “ministra”. L’obiettivo è superare le espressioni percepite come sessiste e favorire una rappresentazione linguistica che rifletta la parità di genere.
Dibattiti, resistenze e alternative lessicali
Nonostante il riconoscimento istituzionale e linguistico, l’introduzione del femminile “architetta” ha suscitato reazioni contrastanti tra le professioniste e la società. Una parte delle donne iscritte all’Ordine degli Architetti preferisce continuare a utilizzare il termine tradizionale “architetto”, percepito come inclusivo e consolidato da quasi un secolo di pratica.
Altre ancora propongono alternative come “architettrice”, termine documentato da almeno quattro secoli e riscoperto recentemente anche in ambito culturale e accademico per la sua aura aulica e distintiva. Sebbene “architettrice” abbia trovato accoglienza in alcune cerchie, resta circoscritto e meno diffuso rispetto a “architetta”, che ormai compare anche su timbri professionali ufficiali e in numerosi atti amministrativi.
I sostenitori di una declinazione neutra affermano che “architetto” sia già un nome comune di genere, simile a “presidente”, e che non necessiti di un femminile specifico, ma le Regole linguistiche favoriscono invece la formazione e l’adozione del femminile là dove possibile, specialmente per promuovere la visibilità delle donne nelle professioni.
Lingua in evoluzione e impatti sociali
L’adozione di “architetta” non si limita a una disputa terminologica; rappresenta il segnale tangibile di una lingua in continuo mutamento, che si confronta con i cambiamenti sociali e le istanze di equità. Il dibattito richiama attenzione non solo alla correttezza formale, ma anche all’importanza dell’identità professionale e del riconoscimento delle differenze di genere.
Le posizioni degli agenti linguistici e degli enti professionali si uniscono a una spinta culturale più ampia, che include la riflessione storica sull’apporto delle donne all’architettura italiana e internazionale, la valorizzazione del contributo di figure femminili nel campo e il superamento di stereotipi radicati. Non è un caso che sempre più donne architetto aspirino a una specificità terminologica che le renda visibili e riconosciute anche sul piano linguistico.
In conclusione, la risposta alle polemiche linguistiche si articola su più livelli: grammaticale, istituzionale, sociale e personale. È corretto e legittimo dire “architetta”; il termine è sostenuto dalla normativa della lingua italiana, dalle istituzioni e dall’evoluzione dei costumi. Tuttavia, la scelta finale rimane libera e personale, inserita in un contesto storico in cui il linguaggio, come la società, continua a evolvere.